Ana
Macarena –
Daniele Semeraro – Castelvecchi – Pagg. 432 –
ISBN 9788832824735 - Euro 19,50
Il
primo libro di Semeraro che leggo è Scrivere
polvere edito
Lupo Editore e credo che sia uno dei migliori libri scritti da
un’emergente, ricordo che rimasi incollata alle pagine fino alla
fine, e oggi, a distanza di anni, ne porto ancora un ricordo
limpido.
Mi approccio a Ana Macarena con una certa titubanza, ho paura di perdere la magia che l’autore mi aveva regalato con la sua prima pubblicazione e invece sono felice di dire che mi sbagliavo. Daniele Semeraro è una conferma e sono certa che farà moltissima strada!
Ana Macarena è tratto da una storia vera, una realtà sconvolgente che spesso ci è molto vicina, nonostante veliamo gli occhi per non guardare.
Mi approccio a Ana Macarena con una certa titubanza, ho paura di perdere la magia che l’autore mi aveva regalato con la sua prima pubblicazione e invece sono felice di dire che mi sbagliavo. Daniele Semeraro è una conferma e sono certa che farà moltissima strada!
Ana Macarena è tratto da una storia vera, una realtà sconvolgente che spesso ci è molto vicina, nonostante veliamo gli occhi per non guardare.
Quando
caddi al mondo aveva quattordici anni. Erano coetanee, lei e la mia
prima madre.
Ana
è una degli abitanti delle fogne di Bucarest. Al di sotto di
Bucarest vive una città che nessuno immagina, è
la città sotterranea che si snoda attraverso la rete fognaria dove
migliaia di persone si sono rifugiate dopo il crollo del regime di
Ceausescu.
“Quelli
che all’epoca erano bambini e orfani, oggi sono adulti che
continuano a resistere per sopravvivere nei sotterranei della
capitale romena.
Il capo della città sotterranea è un uomo sulla trentina che si fa chiamare Bruce Lee i gli abitanti sotterranei girano per la città, chiedendo l’elemosina o frugando nella spazzatura, usata per reperire tutto quello di cui hanno bisogno. È una vita fatta di violenze in cui, soprattutto i bambini, vengono usati per rapporti sessuali a pagamento da turisti che a volte si recano là proprio per questo. È inoltre, e soprattutto, una vita di droga in tutte le sue forme, tra cui spicca l’aurolac una vernice sintetica dalle forti qualità allucinogene che viene sniffata da tutti, ragazzini compresi, ma che ha forti ripercussioni sulla salute delle persone che ne fanno uso. È la droga più popolare in questo mondo perché costa poco (meno di un euro a bottiglia) e permette di evadere dalla realtà. Il dimenticare la propria situazione è l’obiettivo che spinge queste persone a rifugiarsi nella droga e negli effetti che questa procura.” (https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/04/15/news/traffico_di_esserei_umani-83662247/?refresh_ce)
Il capo della città sotterranea è un uomo sulla trentina che si fa chiamare Bruce Lee i gli abitanti sotterranei girano per la città, chiedendo l’elemosina o frugando nella spazzatura, usata per reperire tutto quello di cui hanno bisogno. È una vita fatta di violenze in cui, soprattutto i bambini, vengono usati per rapporti sessuali a pagamento da turisti che a volte si recano là proprio per questo. È inoltre, e soprattutto, una vita di droga in tutte le sue forme, tra cui spicca l’aurolac una vernice sintetica dalle forti qualità allucinogene che viene sniffata da tutti, ragazzini compresi, ma che ha forti ripercussioni sulla salute delle persone che ne fanno uso. È la droga più popolare in questo mondo perché costa poco (meno di un euro a bottiglia) e permette di evadere dalla realtà. Il dimenticare la propria situazione è l’obiettivo che spinge queste persone a rifugiarsi nella droga e negli effetti che questa procura.” (https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/04/15/news/traffico_di_esserei_umani-83662247/?refresh_ce)
Non
conoscevo questa realtà, non in tutta la sua crudezza.
Ana Macarena è un il triste viaggio, un viaggio della speranza di una bambina, ma che si rivelerà il viaggio versoi soprusi, violenze, fatica… verso una morte crudele.
Ana Macarena è un il triste viaggio, un viaggio della speranza di una bambina, ma che si rivelerà il viaggio versoi soprusi, violenze, fatica… verso una morte crudele.
Un
popolo costretto a estirpare le proprie radici per trapiantarle
altrove non può che inselvatichirsi e riavvicinarsi allo stato brado
tipico delle bestie.
Ana
da Bucarest arriva in Italia e qui si apre il mondo spietato del
traffico degli esseri umani, Ana Macarena vuol essere una denuncia, e
per quanto mi riguarda, è doloroso scoprire che il tuo paese è una
delle destinazioni preferite del traffico di esseri umani, un
fenomeno che riguarda tutti i migranti, persone fatte arrivare con
l’inganno di una vita migliore ma che in realtà diverranno
“animali da fatica” sfruttati fino all’osso una volta arrivati
a destinazione.
Ana viaggia da Bucarest al Tavoliere delle Puglie, qui inizia la sua schiavitù fino ad arrivare mesi dopo in Sicilia. “Liberata” arriva a Firenze, dove vedrà uno spiraglio di vita “normale”, ma si dimostrerà una piccola illusione prima della catastrofe.
Ana viaggia da Bucarest al Tavoliere delle Puglie, qui inizia la sua schiavitù fino ad arrivare mesi dopo in Sicilia. “Liberata” arriva a Firenze, dove vedrà uno spiraglio di vita “normale”, ma si dimostrerà una piccola illusione prima della catastrofe.
Più
forzato è il distacco dalle proprie radici, più il vuoto negli
occhi di chi arriva in un Paese straniero per restarci assomiglia a
un pozzo senza fondo. Il mio era di una fissità superficiale, senza
profondità. I miei occhi, allora, erano simili a uno specchio dalla
facciata opaca, privo della funzione riflettente, organi incapaci di
far trasparire emozioni, di svelarle all’esterno.
Nonostante
i soprusi Ana non riesce a ribellarsi, per lei che veniva dalle
fogne, nulla è peggio di ciò che aveva lasciato a Bucarest.
Noi
figli delle fogne abbiamo un rapporto particolare col Signore, con la
sua opera, con la sua presenza. Per noi Dio è rassegnazione. Siamo
nelle sue mani e sappiamo per certo che Lui è grande, come sappiamo
che dobbiamo morire. Questa è una delle risposte autoconsolatorie
che vi darebbe un bambino delle fogne alla domanda: cosa pensi della
tua situazione? Come la vedi? Cosa chiedi a Dio?
Daniele
Semeraro si
conferma un grande narratore, la sua scrittura è pulita e diretta,
non usa fronzoli e non ha paura di raccontare. Un grande plauso
all’autore.
Ana Macarena è un libro da leggere perché certe cose non si possono più accettare nel ventunesimo Secolo.
Ana Macarena è un libro da leggere perché certe cose non si possono più accettare nel ventunesimo Secolo.
Katia
Ciarrocchi
Anna
Karenina –
Lev Tolstoj – Rizzoli – Pagg. XXVII – 1.210 –
ISBN 9788817011525 – Euro 10,90
Saper
leggere
Saper
leggere significa dunque conoscere? Conoscere significa saper
leggere?
Prendo Anna Karenina, mai letto Tolstoj, e letto, rispolvero la biografia, impellente il bisogno di conoscere, inizio a farmi un’idea della sua produzione non per titoli ma per temi e a capire, ma ormai il romanzo è già letto e il danno è fatto: nella mia memoria di lettrice vi si stamperà con queste prime impressioni che, nel tempo, mi appariranno ovvie, scontate, spicciole e del tutto incongruenti rispetto alla complessità dell’autore che ancora non conosco per lettura diretta e integrale.
Prendo Anna Karenina, mai letto Tolstoj, e letto, rispolvero la biografia, impellente il bisogno di conoscere, inizio a farmi un’idea della sua produzione non per titoli ma per temi e a capire, ma ormai il romanzo è già letto e il danno è fatto: nella mia memoria di lettrice vi si stamperà con queste prime impressioni che, nel tempo, mi appariranno ovvie, scontate, spicciole e del tutto incongruenti rispetto alla complessità dell’autore che ancora non conosco per lettura diretta e integrale.
Diamo
tempo al tempo; allo stato attuale questo è il mio sentire.
È un romanzo fresco e moderno per stile e per contenuti eppure è ambientato a fine Ottocento tra Mosca e Pietroburgo, con ampie digressioni sulle condizioni socio-economiche della Russia imperiale di Alessandro II in un’epoca di grandi trasformazioni, una per tutte l’abolizione del vecchio retaggio feudale della servitù della gleba e la conseguente emancipazione dei servi. La modernità risiede nella sua fruibilità nonostante si presenti con la corposità, in termini prettamente numerici circa le pagine, tipica dei romanzi russi; ma è il contenuto che più mi sorprende e con esso la capacità del russo di indagare l’animo umano con rispetto e correttezza riuscendo a consegnare al lettore un ampio ventaglio di casi umani, di sentimenti, di emozioni, di punti di vista, di affascinanti misteri individuali, quali tutti noi siamo. Sono stata impressionata in modo favorevole da questo complesso lavoro di rappresentazione dell’umanità, ho ammirato la capacità dell’autore di dare al lettore la possibilità di farsi una sua personale opinione senza sentirsi influenzato dagli eventi anche quando essi si ponevano con tutta la loro carica emotiva, non sempre positiva. Esco dalla lettura con Levin e Kitty nel cuore, il trionfo della normalità e della semplicità, con un senso di noia rispetto ad Anna pur dispiacendomi il suo destino e la sua parabola di vita, con un misto di rispetto, di commiserazione per suo marito e ancor più per i due figli di Anna, con la consapevole e intelligente rassegnazione di Dolly e con un senso di meraviglia circa la restituzione dei delicati equilibri tra i due sessi soprattutto quando essi sono uniti nel vincolo matrimoniale. Ho spesso pensato che Tolstoj abbia espresso in queste pagine una piena consapevolezza dello schiacciamento sociale subìto dal gentil sesso nel contesto rappresentato e che abbia parteggiato per le donne. Non so se ciò corrisponda al vero, questo ho captato e questo riporto. Mi è piaciuta inoltre l’economia dello scritto, il suo andamento per quadri giustapposti, funzionali a interiorizzare le singole vicende tra esse connesse da una fine rete parentale o dalla frequentazione o dall’appartenenza sociale. Insomma un romanzo perfetto al quale mi sembra difficile attribuire imperfezione alcuna. Non so se ho saputo leggerlo e se una conoscenza più approfondita dell’autore sarebbe stata più funzionale alla lettura, in ogni caso la piacevolezza non può essere dettata da questo aspetto, l’opera si fa amare per la sua essenza che è quella di ogni classico che trascende lo spazio e il tempo per essere sempre apprezzato.
È un romanzo fresco e moderno per stile e per contenuti eppure è ambientato a fine Ottocento tra Mosca e Pietroburgo, con ampie digressioni sulle condizioni socio-economiche della Russia imperiale di Alessandro II in un’epoca di grandi trasformazioni, una per tutte l’abolizione del vecchio retaggio feudale della servitù della gleba e la conseguente emancipazione dei servi. La modernità risiede nella sua fruibilità nonostante si presenti con la corposità, in termini prettamente numerici circa le pagine, tipica dei romanzi russi; ma è il contenuto che più mi sorprende e con esso la capacità del russo di indagare l’animo umano con rispetto e correttezza riuscendo a consegnare al lettore un ampio ventaglio di casi umani, di sentimenti, di emozioni, di punti di vista, di affascinanti misteri individuali, quali tutti noi siamo. Sono stata impressionata in modo favorevole da questo complesso lavoro di rappresentazione dell’umanità, ho ammirato la capacità dell’autore di dare al lettore la possibilità di farsi una sua personale opinione senza sentirsi influenzato dagli eventi anche quando essi si ponevano con tutta la loro carica emotiva, non sempre positiva. Esco dalla lettura con Levin e Kitty nel cuore, il trionfo della normalità e della semplicità, con un senso di noia rispetto ad Anna pur dispiacendomi il suo destino e la sua parabola di vita, con un misto di rispetto, di commiserazione per suo marito e ancor più per i due figli di Anna, con la consapevole e intelligente rassegnazione di Dolly e con un senso di meraviglia circa la restituzione dei delicati equilibri tra i due sessi soprattutto quando essi sono uniti nel vincolo matrimoniale. Ho spesso pensato che Tolstoj abbia espresso in queste pagine una piena consapevolezza dello schiacciamento sociale subìto dal gentil sesso nel contesto rappresentato e che abbia parteggiato per le donne. Non so se ciò corrisponda al vero, questo ho captato e questo riporto. Mi è piaciuta inoltre l’economia dello scritto, il suo andamento per quadri giustapposti, funzionali a interiorizzare le singole vicende tra esse connesse da una fine rete parentale o dalla frequentazione o dall’appartenenza sociale. Insomma un romanzo perfetto al quale mi sembra difficile attribuire imperfezione alcuna. Non so se ho saputo leggerlo e se una conoscenza più approfondita dell’autore sarebbe stata più funzionale alla lettura, in ogni caso la piacevolezza non può essere dettata da questo aspetto, l’opera si fa amare per la sua essenza che è quella di ogni classico che trascende lo spazio e il tempo per essere sempre apprezzato.
Siti
I
cento giorni –
Joseph Roth – Adelphi – Pagg. 224 – ISBN 9788845911057 –
Euro 14,00
Al
tramonto
Ecco
l’ennesimo Roth, per me.
In quale dimensione siamo stavolta?
Il romanzo, apparso nel 1935, viene catalogato come romanzo storico e il titolo richiama subito l’epilogo della parabola napoleonica. Siamo lì, apparentemente, ma non dentro quel periodo storico, no, non totalmente. Dietro lo schermo del resoconto degli ultimi giorni da imperatore di Napoleone, dall’Elba a Waterloo, con focalizzazione quasi assoluta sull’uomo solo e vinto e debole alla quale fa da contraltare la vicenda parallela di un umile stiratrice della sua corte, Angelina Pietri, corsa come lui, si cela in realtà, netto, il fantasma di un altro imperatore, di un’altra guerra, di un altro soldato, di un altro periodo storico e per finire di un altro straniero dentro i confini di un impero che si sta dissolvendo.
Insomma, insieme ai suoi più noti “La marcia di Radetzky” e “La cripta dei cappuccini”, anche questo è, a suo modo, un libro sul finis Austriae e ci riporta a quella prosa nostalgica, necessaria per rendere il senso di smarrimento che accompagnò nei sudditi la fine dell’impero asburgico. Le atmosfere sono le stesse, cambiano i personaggi, Napoleone è come Francesco Giuseppe, smarrito e piccolo e ancora acclamato mentre abdica, Waterloo segna la fine di un mito fatto uomo come la resa austriaca la morte dell’impero austroungarico, il suolo della patria francese trema per il polacco Wokurka, ex soldato ora calzolaio che protegge Angelina quando durante il ritorno del re è estromessa dalla corte, come tremò per un povero galiziano con la disgregazione del mito asburgico e per ogni povero reduce della Grande Guerra.
Per chi conosce i temi più importanti della produzione dello scrittore i paralleli sorgono spontanei, e piacevolmente si gode di questa trasposizione della vicenda napoleonica; qui l’imperatore è restituito nella sua dimensione umana, sia nei momenti di gloria, come quest’ultimo colpo di coda, sia nel momento della sua caduta. Ad essa in particolare è dedicata la terza delle quattro sezioni di cui si compone il romanzo, Tramonto, la più intensa, la più bella, la più accorata, scandita dalla Preghiera alla morte, dalla caratterizzazione dell’imperatore sulla stregua del Giobbe biblico (e qui vi consiglio uno dei suoi romanzi più belli, Giobbe, appunto), dal ridimensionamento del delirio di onnipotenza che ci presenta ora un essere umano stanco e più conciliante, più vicino alla dimensione minima dell’esistenza, capace di far tramontare la sua stella, dopo aver dominato il mondo, a quarantasei anni appena. Votato infine ad un altruismo che gli consente di consolare gli altri: “Non curatevi di me, il mio destino si compie da solo”, per consegnarsi prigioniero al nemico.
Per me, bellissimo. Vi lascio però alle suggestioni infinite prodotte da questo uomo nella letteratura e sapientemente ripercorse da Giuseppe Scaraffia nell’ articolo di cui vi offro il link:
http://www.repubblica.it/venerdi/articoli/2017/10/25/news/napoleone_bonaparte_simon_scarrow_mostra_torino-179279123/
In quale dimensione siamo stavolta?
Il romanzo, apparso nel 1935, viene catalogato come romanzo storico e il titolo richiama subito l’epilogo della parabola napoleonica. Siamo lì, apparentemente, ma non dentro quel periodo storico, no, non totalmente. Dietro lo schermo del resoconto degli ultimi giorni da imperatore di Napoleone, dall’Elba a Waterloo, con focalizzazione quasi assoluta sull’uomo solo e vinto e debole alla quale fa da contraltare la vicenda parallela di un umile stiratrice della sua corte, Angelina Pietri, corsa come lui, si cela in realtà, netto, il fantasma di un altro imperatore, di un’altra guerra, di un altro soldato, di un altro periodo storico e per finire di un altro straniero dentro i confini di un impero che si sta dissolvendo.
Insomma, insieme ai suoi più noti “La marcia di Radetzky” e “La cripta dei cappuccini”, anche questo è, a suo modo, un libro sul finis Austriae e ci riporta a quella prosa nostalgica, necessaria per rendere il senso di smarrimento che accompagnò nei sudditi la fine dell’impero asburgico. Le atmosfere sono le stesse, cambiano i personaggi, Napoleone è come Francesco Giuseppe, smarrito e piccolo e ancora acclamato mentre abdica, Waterloo segna la fine di un mito fatto uomo come la resa austriaca la morte dell’impero austroungarico, il suolo della patria francese trema per il polacco Wokurka, ex soldato ora calzolaio che protegge Angelina quando durante il ritorno del re è estromessa dalla corte, come tremò per un povero galiziano con la disgregazione del mito asburgico e per ogni povero reduce della Grande Guerra.
Per chi conosce i temi più importanti della produzione dello scrittore i paralleli sorgono spontanei, e piacevolmente si gode di questa trasposizione della vicenda napoleonica; qui l’imperatore è restituito nella sua dimensione umana, sia nei momenti di gloria, come quest’ultimo colpo di coda, sia nel momento della sua caduta. Ad essa in particolare è dedicata la terza delle quattro sezioni di cui si compone il romanzo, Tramonto, la più intensa, la più bella, la più accorata, scandita dalla Preghiera alla morte, dalla caratterizzazione dell’imperatore sulla stregua del Giobbe biblico (e qui vi consiglio uno dei suoi romanzi più belli, Giobbe, appunto), dal ridimensionamento del delirio di onnipotenza che ci presenta ora un essere umano stanco e più conciliante, più vicino alla dimensione minima dell’esistenza, capace di far tramontare la sua stella, dopo aver dominato il mondo, a quarantasei anni appena. Votato infine ad un altruismo che gli consente di consolare gli altri: “Non curatevi di me, il mio destino si compie da solo”, per consegnarsi prigioniero al nemico.
Per me, bellissimo. Vi lascio però alle suggestioni infinite prodotte da questo uomo nella letteratura e sapientemente ripercorse da Giuseppe Scaraffia nell’ articolo di cui vi offro il link:
http://www.repubblica.it/venerdi/articoli/2017/10/25/news/napoleone_bonaparte_simon_scarrow_mostra_torino-179279123/
Siti
I
Gonzaga Storia
e segreti - Kate
Simon - Newton Compton – Pagg. 364 - ISBN 9788882895730 - Euro
10,00
I
Gonzaga e il Rinascimento
A
essere sincero, quando ne ho iniziato la lettura affrontando il primo
capitolo interlocutorio e, soprattutto, quando mi sono imbattuto
nell’Interludio intestato La
peste ho
perso la voglia di proseguire, perché, francamente, come incipit non
è assolutamente invitante; poi, mi sono imposto di andare avanti e
la mia decisione si è rivelata giusta, perché l’opera è di
pregevole fattura. Non era certo facile narrare dell’ascesa, delle
glorie e poi della decadenza del casato dei Gonzaga perché si
trattava di avere a che fare con quattro secoli di storia e
soprattutto con quel periodo così fecondo per tutte le arti e che è
rappresentato dal Rinascimento. Kate Simon si è dimostrata
consapevole di queste difficoltà, ma, anziché limitarsi a un puro e
semplice, per quanto valido saggio storico sui Gonzaga, ha inteso
andar oltre, proponendo al lettore, attraverso le vicende dei Signori
di Mantova, un quadro ampio e affascinante del Rinascimento. Riesce a
far questo senza perdere di vista l’argomento principale, anzi il
lettore, attratto dalle trame ordite dai Gonzaga, dalle loro alterne
fortune e dallo splendore che seppero dare a una piccola corte,
finirà con il ritrarre un vero piacere nell’essere edotto di un
periodo storico, sovente mitizzato, ma qui presentato nella sua nuda
realtà costituita da splendore e miseria, da trionfo delle arti e
onnipresenti intrighi, da uomini encomiabili e da altri esecrabili.
Non sono facile alle lodi sperticate, ma in questo caso, visto
l’ambizioso fine e la non comune difficoltà per raggiungerlo,
difficoltà abilmente superata, posso dire in tutta consapevolezza
che questo saggio relativo proprio al periodo rinascimentale è uno
dei migliori che ho letto. Fra l’altro, pur mostrando una certa
simpatia per questa famiglia di agricoltori, che, grazie alle fortune
accumulate con i frutti della terra, seppe assurgere al rango di
nobiltà, facendo diventare la piccola corte di Mantova un punto di
preciso riferimento in tutta l’Europa, l’autore non fa sconti,
disegnando ritratti a volte impietosi di questi Signori, ben
evidenziando i loro pregi e i loro difetti, smitizzando alcuni di
essi e ricollocandoli nella corretta posizione di persone magari
capaci e influenti, ma certamente non prive di vizi, vizi che in
tutte le epoche e forse anche di più nel Rinascimento sono propri
del genere umano. Ciò che più colpisce, però, è l’inserimento
nella narrazione cronologica delle vite dei Gonzaga di parti
chiamate Interludi e
che potrebbero far pensare, di primo acchito, come è appunto
capitato a me, a delle inopportune digressioni. E invece si rivelano
interessanti e indispensabili per comprendere come la storia di una
famiglia non possa prescindere dal contesto vigente pro tempore dei
grandi fatti e delle arti. Senza citarli tutti, per ovvie ragioni di
spazio, segnalo quello dedicato a un grande pedagogo quale fu
Vittorino da Feltre, un altro che parla di due autentici virtuosi
dell’arte, quali furono per la pittura Andrea Mantegna e per
l’architettura Leon Battista Alberti, nonché quello con cui viene
dato, per sommi, ma esaurienti capi, un sunto di opere ancor oggi di
estremo interesse quali furono Il
cortegiano di
Baldassarre Castiglione e Il
Principe di
Nicolò Machiavelli; non posso inoltre dimenticare l’excursus
dedicato al teatro e alla musica, che completa nel migliore dei modi
un affresco di grande bellezza.
Il
libro si conclude, mestamente, con la fine della grande casata, con
tutte le opere di grande valore, acquistate nei secoli dai Gonzaga,
che lasciano il Palazzo Ducale, disperse nel mondo, per l’ignavia e
la scelleratezza degli ultimi discendenti. La luce non si spegne di
colpo, ma gradualmente e rimarrà spenta per il periodo di
dominazione austriaca, francese, di nuovo austriaca e del nuovo stato
italiano, per poi tornare a rifulgere a partire dal dopoguerra,
accelerando la vocazione turistica della città di Mantova a partire
dall’ultimo decennio del secolo scorso. Mantova, senza i Gonzaga,
sarebbe rimasto un umile borgo agricolo ed è per questo motivo che
dobbiamo essere riconoscenti a questa dinastia, che proietta il
concetto del bello rinascimentale ai giorni nostri.
Da
leggere, senza alcun dubbio.
Kate
Simon (5
dicembre 1912 - 4 febbraio 1990) è stato un autore americano di
origine polacca e noto anche come Larry.
Ha
scritto, fra l’altro, Fifth Avenue: A Very Social Story (1978), è
una storia sociale di Manhattan. A Renaissance Tapestry: The Gonzaga
of Mantua (1988) racconta la storia del Rinascimento attraverso la
storia della famiglia Gonzaga.
Renzo
Montagnoli
La
reale natura della guerra? Normale crudeltà
«Il
macellaio» racconta il clima che portò al primo conflitto mondiale
Il
capolavoro di Sandor
Marai (1900-1989)
sarà considerato per sempre «LeBraci», tanto che Giulio
Nascimbeni, uno dei migliori critici letterari del Corriere della
Sera, che non è più fra noi, formatosi nelle pagine dell’Arena,
usava dire, per eccesso, che chi ha letto questo romanzo, potrebbe
astenersi dal leggere qualsiasi altra cosa.
Comunque,
Marai, vissuto fino a quasi novant’anni, è stato molto prolifico
come scrittore, quasi perseguitato, nella sua folta produzione, dal
tema del destino e dalle sue traiettorie modificate dalle azioni
eclatanti o impercettibili di uomini e donne. Questo persistente
assunto lo troviamo in particolate ne «L’isola», ne
«L’eredità di Eszster» del 1939 e ne «La donna giusta» del
1941.
«Il
macellaio» di
cui stiamo trattando ora (Adelphi,
pp.98, euro 10, nella bella traduzione di Laura Sgarioto),
presenta per così dire una variante, rispetto le opere precedenti,
cui abbiamo accennato, qui il destino sembra restare indipendente,
avulso dalle azioni umane, e non appare nemmeno un ingombrante
intruso che scombini e condizioni l’agire dei protagonisti. Qui è
la forza prorompente e incontenibile della natura che agisce. Come
una tara ereditaria, è un’agghiacciante esempio di abiezione
spontanea, naturale e ragionevole: uccidere animali in un mattatoio o
soldati nemici in guerra non fa una grande differenza per Otto
Schwarz, il protagonista.
Nell’ottica
dell’Autore, continua ad essere la guerra lo stolido e pericoloso
palcoscenico della follia delle nazioni che, inconsideratamente, vi
aderiscono.
Se
sotto «Le Braci» si sottendevano la Prima e la Seconda guerra
mondiale, nel «Macellaio» uccidere in guerra diventa qualcosa di
inevitabile come una naturale vocazione, come un elemento che
portiamo nel nostro DNA cui non possiamo sottrarci.
Le
aspre pagine dell’incipit che ci narrano sotto quali infausti
presagi viene concepito Otto, figlio di un sellaio di una cittadina
del margravio del Brandeburgo, negli ultimi anni dell’Ottocento
(«Nacque di dieci mesi e con i denti. Il parto costò la vita alla
madre») ci fanno subito capire – come rileva acutamente anche
Laura Sgarioto, traduttrice dell’aspro romanzo – che l’animo
brutale del personaggio anticipa la figura di Moosbrugger, il
memorabile criminale de «L’uomo senza qualità» di Musil.
Marai
ha saputo concentrare in un personaggio l’incontenibile
sommovimento psichico che condusse alla prima guerra mondiale e
devastò gli anni successivi. Ma racconta tutto questo con la
pacatezza, con lo scrupolo e la concisione di un cronista, come
qualcosa che appartiene a una nuova, terrificante normalità.
Otto,
un giorno, vede un macellaio all’opera «la scure scintillava
al sole, come gli occhi della mucca, che egli scrutò da vicino e
sulla cui cornea si rifletteva placidamente la rimessa, la taverna, i
carri e la sua stessa immagine. L’istante in cui vide balenare la
scure e subito dopo l’animale stramazzare a terra, s’impresse in
lui come il ricordo di una sorta di gioia trionfale».
Marai
ci conduce abilmente per mano verso l’epilogo del parossismo della
crudeltà, con la consueta magistrale prosa intelligente e pacata,
tipica del grande auto
Grazia
Giordani
La
pace mancata del 1919;gli errori del vertice di Parigi
Nella capitale si decisero i destini del mondo dopo la Grande Guerra.
Nella capitale si decisero i destini del mondo dopo la Grande Guerra.
Certo che capita raramente di leggere con lo stesso coinvolgimento che si presta ad un bel romanzo, un saggio storico come quello di Franco Cardini, dal sintetico titolo «La pace mancata» (Mondadori, pp.240, euro 22, collaborazione al testo di Sergio Valzania). La visione critica di Cardini ci fa entrare nel complesso milieu di fatti storici che i testi scolastici tradizionali per imperizia o per scarso senso critico, non avevano e non hanno contemplato con pari lucidità. Così apprendiamo che fra il gennaio 1919 e quello del 1920, a Parigi si decise il destino del mondo. Al termine del grande conflitto che secondo la promessa wilsoniana, avrebbe dovuto «porre fine a tutte le guerre», in un momento decisivo per un possibile riscatto, dopo anni di atrocità, i leader delle quattro potenze vincitrici si riunirono nella capitale francese per discutere i termini della pace, ridisegnando i confini politici e ristabilendo gli equilibri dell’Europa e del mondo. A Parigi si riunirono Woodrow Wilson, Lloyd George, Clemenceau e Orlando Ed ebbero un potere che nessun altro aveva mai avuto prima, ma il loro operato fu un vero disastro.
«Accettare Parigi come sede della Conferenza non fu che uno anche se forse il più grave, degli errori commessi prima ancora che i negoziati avessero inizio (. . .) il presidente Woodrow Wilson decise di assumere personalmente il compito di plenipotenziario statunitense (. . .) Wilson si espose senza schermi allo svolgersi delle trattative e portò quindi le maggiori responsabilità per gli esiti che esse ebbero».
La trattativa che avrebbe dovuto essere un ordine fondato sulla giustizia e il rispetto dei diritti dei popoli, anche per il razzismo e le idee arroganti di Wilson, non fu in grado di dare al continente e al mondo intero un assetto giusto e pacifico.
Ai vinti vennero imposte dure condizioni spesso a scopo vendicativo o sotto la minaccia di continuare ad affamare la popolazione civile.
Sulle rovine degli imperi sconfitti nacquero nuovi stati in cui si affermarono i nazionalismi più gretti da cui scaturirono problemi insolubili e numerose guerre locali.
Le decisioni prese riguardanti la Germania sconfitta, confortata da piccoli Stati con forti minoranze tedesche, contribuirono in maniera fatale alla salita al potere di Hitler.
Il presidente Wilson, del tutto digiuno di vis diplomatica -l’uomo sbagliato al posto sbagliato -, peggiorò quella situazione già annodatissima postbellica, portando i risultati verso la costituzione della Società delle Nazioni, alla quale, paradossalmente, gli stessi Stati Uniti non aderirono. Non si può operare, come fece Wilson, in circostanze così determinanti per il mondo intero, se si è digiuni di astuzie atte al saper negoziare.
Il duo Cardini Vallanzania ripercorre con lucida intelligenza critica i fatti ignoti alla maggior parte di noi, che pure amiamo la Storia, occorsi a Parigi in quell’anno fondamentale, quel 1919 da cui scaturì la pace mancata.
Quasi fossimo provvisti di un’ipotetica moviola, possiamo esaminare, alla luce del prezioso testo, le vicende che precedettero e seguirono la firma dei trattati di pace con i paesi sconfitti. E Cardini, fin dall’incipit del saggio afferma di essere dalla parte dei vinti. In buona sostanza, la Conferenza di Pace del 1919 per i suoi protagonisti – il più volte citato Woodrow Wilson e i primi ministri Lloyd George, Clemenceau e Orlando –fu l’occasione mancata di stabilire un giusto ordine internazionale. I quattro leader ebbero nelle loro mani i destini del mondo, ma costruirono una pace che ha dato solo frutti bacati.
Franco
Cardini è professore emerito di storia medievale presso l’Istituto
Italiano di Scienze umane e sociali/Scuola normale superiore e
Directeur de Recherches nell’ École des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi, nonché Fellow della Harward University.
Sergio
Valanzania storico e studioso della comunicazione, autore radiofonico
e televisivo, ha diretto programmi radiofonici della Rai. Scritto su
LA NAZIONE, AVVENIRE, LA REPUBBLICA, IL GIORNALE, L’INDIPENDENTE,
LIBER
Grazia
Giordani
La
punizione –
Tahar Ben Jelloun – La nave di Teseo – Pagg. 138 –
ISBN 9788893445214 – Euro 17,00
Il
valore della libertà
Ci
sono voluti quasi cinquant’anni prima che Tahar Ben Jelloun
trovasse le parole giuste per raccontare la sua storia. Proprio lui,
che, di storie, ne ha scritte una infinità, paradossalmente, non
riusciva a scrivere la propria. Perché quella narrata ne “La
punizione”, il nuovo romanzo dello scrittore marocchino nativo di
Fes e residente da lungo tempo in Francia, è una vicenda che sa di
memoria e profonda amarezza. Un viaggio a ritroso seguendo le pesanti
orme del tempo, una rielaborazione dolorosa ma necessaria di quanto
accaduto tanti anni fa per poter chiudere i conti con un passato che
non è possibile cancellare né ignorare del tutto.
Era il marzo del 1965 quando gruppi di studenti universitari manifestarono pacificamente per le strade di Rabat e Casablanca; in quell’occasione, la repressione, piuttosto brutale, non si fece attendere. Tra quei ragazzi, c’era anche Tahar Ben Jelloun, all’epoca studente di filosofia. L’anno seguente, per lui e una novantina di altri giovani che erano stati segnalati, la “punizione” bussò alla porta di casa sotto forma di perentoria convocazione a presentarsi presso uno sperduto campo militare nelle vicinanze della città di Meknès, nel nord del Paese. Era l’epoca in cui molta gente spariva all’improvviso, inghiottita dalla cieca violenza del regime dell’allora sovrano Hassan II, e si viveva in un continuo clima di paura; esercito e polizia, avendo carta bianca, facevano ricorso a qualunque mezzo pur di reprimere ogni possibile dissenso. La monarchia ’alawide offriva il volto forse peggiore di tutta la sua storia.
“Cosa abbiamo fatto di così grave? Organizzarci legalmente, manifestare pacificamente, reclamare libertà e rispetto.”
Per tutta risposta, vennero spediti anzitutto al campo militare di El Hajeb, dove ebbe così inizio un vero e proprio internamento, il cui scopo ufficiale era quello di rieducarli e insegnar loro a diventare bravi cittadini, all’insegna del vecchio e abusato slogan “Allah, al-watan, al-malik” (“Dio, la patria, il re”) che ancora oggi si vede scritto a grandi caratteri e disseminato qua e là per il Marocco. A scandire le lunghe giornate in quel luogo poco ameno si susseguivano maltrattamenti, umiliazioni, privazioni di ogni genere alla completa mercé di comandanti militari semianalfabeti, psicopatici e privi di scrupoli, spesso in preda a delirio di onnipotenza.
Picchiati, denutriti, sporchi e infreddoliti, con i capelli costantemente rasati a zero, i “puniti” venivano tenuti nel più totale isolamento, senza che le rispettive famiglie sapessero ciò che in realtà accadeva; per di più, perdere la vita per il minimo accenno di ribellione o a causa di pericolose simulazioni di operazioni di guerra (non mancavano, infatti, le tensioni con la vicina Algeria) rischiava di essere tutt’altro che improbabile. Il giovane Tahar trascorse oltre un anno e mezzo in quello stato di detenzione, mentre a sostenerlo accorrevano, per fortuna, la tenacia della sua poesia, il profondo amore per la letteratura e, da grande appassionato di cinema quale era, la magia delle immagini dei film che amava, come quelle di Charlie Chaplin nei panni di Charlot.
“[…] di fronte alla sensibilità, alla intelligenza, il potere oppone la brutalità e la stupidità. La prima arma è l’umiliazione, questa violenza che consiste nel declassarci, nel metterci sull’orlo del baratro minacciandoci di darci un calcio nella pancia. Mi aggrappo ai ricordi delle mie letture; non so se recito fedelmente ciò che ho letto o invento delle frasi. Ho in mente Dostoevskij, ?echov, Kafka, Victor Hugo… […] Nella mia testa sfilano scene dai film di Charlie Chaplin. Perché il bravo Charlot viene a trovarmi in questa terra ingrata e macchiata da militari abietti? Ne rido di nascosto […] Quell’omino che riesce a ridicolizzare i violenti che lo perseguitano mi ossessiona. Quel genio ha vendicato milioni di umiliati nel mondo. Ecco, questa era la sua missione, il suo disegno. Grazie, Charlot.”
Poi, inattesa e quasi irreale, la fine della prigionia, anche se le sue catene sembravano trascinarsi pure nella vita civile (“Sono stato liberato ma non sono libero.”). La vera liberazione, non a caso, arriverà soltanto diverso tempo dopo e a seguito di un evento davvero sorprendente e imprevedibile…
Una prosa che cattura fin dalle prime battute, appassionante ed estremamente fluida per un romanzo che si fa testimonianza diretta, viva, palpitante e che riconferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, le straordinarie doti di narratore di Tahar Ben Jelloun, nome tra i più noti e apprezzati sulla scena letteraria internazionale. Il suo linguaggio semplice e chiaro che si propone con garbo, le sue denunce, i suoi messaggi di pace e tolleranza religiosa (a tal proposito, invito a leggere le bellissime e istruttive pagine del breve saggio “L’Islam spiegato ai nostri figli”, Bompiani, 2001), il suo chiamare tutto col proprio nome e raccontare le cose così come stanno senza edulcorazioni di sorta fanno di lui un autore particolarmente interessante da seguire. Quest’ultimo suo lavoro, nello specifico, come spesso accade in molte opere della vastissima produzione di Ben Jelloun, punta l’attenzione su un Paese, il Marocco, dietro la cui immagine patinata di meta turistica più o meno a buon mercato persistono problemi assai gravi, quali tortura per dissenso politico, sempre mal tollerato dalle autorità, e corruzione abnorme che rallenta l’apparato burocratico e calpesta i diritti dei cittadini, sebbene sotto l’attuale sovrano Mohammed VI, non certo temuto come il terribile padre Hassan II, siano stati realizzati importanti ma non ancora sufficienti cambiamenti.
Infine, un romanzo che, attraverso la vicenda personale del suo autore, ci parla del valore della libertà, di quanto essa sia preziosa per la nostra dignità di esseri umani e di come, talvolta, basti davvero poco per perderla.
“Sarei potuto uscire dal campo cambiato, indurito, adepto della forza e anche della violenza, ma sono uscito com’ero entrato, pieno di illusioni e tenerezza per l’umanità. So che mi sbaglio. Ma senza quella prova e quelle ingiustizie non avrei mai potuto scrivere.”
Era il marzo del 1965 quando gruppi di studenti universitari manifestarono pacificamente per le strade di Rabat e Casablanca; in quell’occasione, la repressione, piuttosto brutale, non si fece attendere. Tra quei ragazzi, c’era anche Tahar Ben Jelloun, all’epoca studente di filosofia. L’anno seguente, per lui e una novantina di altri giovani che erano stati segnalati, la “punizione” bussò alla porta di casa sotto forma di perentoria convocazione a presentarsi presso uno sperduto campo militare nelle vicinanze della città di Meknès, nel nord del Paese. Era l’epoca in cui molta gente spariva all’improvviso, inghiottita dalla cieca violenza del regime dell’allora sovrano Hassan II, e si viveva in un continuo clima di paura; esercito e polizia, avendo carta bianca, facevano ricorso a qualunque mezzo pur di reprimere ogni possibile dissenso. La monarchia ’alawide offriva il volto forse peggiore di tutta la sua storia.
“Cosa abbiamo fatto di così grave? Organizzarci legalmente, manifestare pacificamente, reclamare libertà e rispetto.”
Per tutta risposta, vennero spediti anzitutto al campo militare di El Hajeb, dove ebbe così inizio un vero e proprio internamento, il cui scopo ufficiale era quello di rieducarli e insegnar loro a diventare bravi cittadini, all’insegna del vecchio e abusato slogan “Allah, al-watan, al-malik” (“Dio, la patria, il re”) che ancora oggi si vede scritto a grandi caratteri e disseminato qua e là per il Marocco. A scandire le lunghe giornate in quel luogo poco ameno si susseguivano maltrattamenti, umiliazioni, privazioni di ogni genere alla completa mercé di comandanti militari semianalfabeti, psicopatici e privi di scrupoli, spesso in preda a delirio di onnipotenza.
Picchiati, denutriti, sporchi e infreddoliti, con i capelli costantemente rasati a zero, i “puniti” venivano tenuti nel più totale isolamento, senza che le rispettive famiglie sapessero ciò che in realtà accadeva; per di più, perdere la vita per il minimo accenno di ribellione o a causa di pericolose simulazioni di operazioni di guerra (non mancavano, infatti, le tensioni con la vicina Algeria) rischiava di essere tutt’altro che improbabile. Il giovane Tahar trascorse oltre un anno e mezzo in quello stato di detenzione, mentre a sostenerlo accorrevano, per fortuna, la tenacia della sua poesia, il profondo amore per la letteratura e, da grande appassionato di cinema quale era, la magia delle immagini dei film che amava, come quelle di Charlie Chaplin nei panni di Charlot.
“[…] di fronte alla sensibilità, alla intelligenza, il potere oppone la brutalità e la stupidità. La prima arma è l’umiliazione, questa violenza che consiste nel declassarci, nel metterci sull’orlo del baratro minacciandoci di darci un calcio nella pancia. Mi aggrappo ai ricordi delle mie letture; non so se recito fedelmente ciò che ho letto o invento delle frasi. Ho in mente Dostoevskij, ?echov, Kafka, Victor Hugo… […] Nella mia testa sfilano scene dai film di Charlie Chaplin. Perché il bravo Charlot viene a trovarmi in questa terra ingrata e macchiata da militari abietti? Ne rido di nascosto […] Quell’omino che riesce a ridicolizzare i violenti che lo perseguitano mi ossessiona. Quel genio ha vendicato milioni di umiliati nel mondo. Ecco, questa era la sua missione, il suo disegno. Grazie, Charlot.”
Poi, inattesa e quasi irreale, la fine della prigionia, anche se le sue catene sembravano trascinarsi pure nella vita civile (“Sono stato liberato ma non sono libero.”). La vera liberazione, non a caso, arriverà soltanto diverso tempo dopo e a seguito di un evento davvero sorprendente e imprevedibile…
Una prosa che cattura fin dalle prime battute, appassionante ed estremamente fluida per un romanzo che si fa testimonianza diretta, viva, palpitante e che riconferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, le straordinarie doti di narratore di Tahar Ben Jelloun, nome tra i più noti e apprezzati sulla scena letteraria internazionale. Il suo linguaggio semplice e chiaro che si propone con garbo, le sue denunce, i suoi messaggi di pace e tolleranza religiosa (a tal proposito, invito a leggere le bellissime e istruttive pagine del breve saggio “L’Islam spiegato ai nostri figli”, Bompiani, 2001), il suo chiamare tutto col proprio nome e raccontare le cose così come stanno senza edulcorazioni di sorta fanno di lui un autore particolarmente interessante da seguire. Quest’ultimo suo lavoro, nello specifico, come spesso accade in molte opere della vastissima produzione di Ben Jelloun, punta l’attenzione su un Paese, il Marocco, dietro la cui immagine patinata di meta turistica più o meno a buon mercato persistono problemi assai gravi, quali tortura per dissenso politico, sempre mal tollerato dalle autorità, e corruzione abnorme che rallenta l’apparato burocratico e calpesta i diritti dei cittadini, sebbene sotto l’attuale sovrano Mohammed VI, non certo temuto come il terribile padre Hassan II, siano stati realizzati importanti ma non ancora sufficienti cambiamenti.
Infine, un romanzo che, attraverso la vicenda personale del suo autore, ci parla del valore della libertà, di quanto essa sia preziosa per la nostra dignità di esseri umani e di come, talvolta, basti davvero poco per perderla.
“Sarei potuto uscire dal campo cambiato, indurito, adepto della forza e anche della violenza, ma sono uscito com’ero entrato, pieno di illusioni e tenerezza per l’umanità. So che mi sbaglio. Ma senza quella prova e quelle ingiustizie non avrei mai potuto scrivere.”
Laura
Vargiu
La
storia –
Elsa Morante – Einaudi – Pagg. XXXII-672 –
ISBN 9788806219642 – Euro 16,00
Storia
e storie
Come
tutte le piccole storie umane, anche quella di Ida e Useppe Ramundo
si perde nella grande Storia e a essa s'intreccia, al tempo stesso,
correndo in parallelo.
Elsa Morante, con una maestria disarmante e forse unica, ci narra la loro povera vicenda in questo romanzo che definire monumentale è poca cosa. Una voce coinvolgente, la sua, capace di scandagliare sentimenti ed emozioni di protagonisti e personaggi vari, nonché di accompagnare il lettore fra le strade di una Roma misera e ferita, ben lontana dai fasti baldanzosi e arroganti del Ventennio. Ed ecco riemergere da queste pagine di una intensità sconvolgente le macerie ancora fumanti di San Lorenzo o la sfollata desolazione di Pietralata o, ancora, i vicoli ormai condannati del Ghetto; dal baratro affannoso del tempo si leva anche il vocio incessante dei vagoni bestiame con il proprio tragico carico umano, in attesa di partenza dalla stazione Tiburtina.
Elsa Morante, con una maestria disarmante e forse unica, ci narra la loro povera vicenda in questo romanzo che definire monumentale è poca cosa. Una voce coinvolgente, la sua, capace di scandagliare sentimenti ed emozioni di protagonisti e personaggi vari, nonché di accompagnare il lettore fra le strade di una Roma misera e ferita, ben lontana dai fasti baldanzosi e arroganti del Ventennio. Ed ecco riemergere da queste pagine di una intensità sconvolgente le macerie ancora fumanti di San Lorenzo o la sfollata desolazione di Pietralata o, ancora, i vicoli ormai condannati del Ghetto; dal baratro affannoso del tempo si leva anche il vocio incessante dei vagoni bestiame con il proprio tragico carico umano, in attesa di partenza dalla stazione Tiburtina.
E
poi la miseria più nera, la fame, sprazzi di lotta partigiana,
mentre la Storia prosegue indifferente il suo cammino e la carne da
macello continua a essere immolata sull'altare blasfemo della
guerra.
Una scrittura magnifica e potente che si fa strepito di fucili e stupore di bambino, canzoni d'anarchia e ninnenanne perdute tra parentesi evanescenti d'infanzia; una scrittura altresì commovente e profonda che si cala nei vernacoli o nel cuore parlante delle bestie di sincera umanità e, con discrezione, s'insinua nella stantìa promiscuità di periferia, così come nei ricordi e nelle speranze deluse, nei pensieri e nei deliri incoscienti, raccontando ritorni e non ritorni da una guerra che, in verità, non finisce mai del tutto perché, per riprendere le parole di Primo Levi, “guerra è sempre”.
Struggenti e destinati a persistere nella memoria i personaggi di Useppe e Ida, meri pulviscoli in quel cielo sterminato di fragili stelle che è il mondo. Travolgente quello di Nino, drammaticamente sfuggente e ombroso quello di Davide. Ogni presenza all'interno dell'intreccio narrativo è ben collocata, nessun incontro sembra essere lasciato al caso, nemmeno quelli di passaggio che spargono “4 parole in tutto d'italiano” e altrettante poche noncuranti gocce di vita. Non ci sono parole con cui riassumere la trama de “La storia”, se non quelle dell'autrice stessa. Un'opera, dunque, da leggere e custodire dolorosamente nel cuore.
Una scrittura magnifica e potente che si fa strepito di fucili e stupore di bambino, canzoni d'anarchia e ninnenanne perdute tra parentesi evanescenti d'infanzia; una scrittura altresì commovente e profonda che si cala nei vernacoli o nel cuore parlante delle bestie di sincera umanità e, con discrezione, s'insinua nella stantìa promiscuità di periferia, così come nei ricordi e nelle speranze deluse, nei pensieri e nei deliri incoscienti, raccontando ritorni e non ritorni da una guerra che, in verità, non finisce mai del tutto perché, per riprendere le parole di Primo Levi, “guerra è sempre”.
Struggenti e destinati a persistere nella memoria i personaggi di Useppe e Ida, meri pulviscoli in quel cielo sterminato di fragili stelle che è il mondo. Travolgente quello di Nino, drammaticamente sfuggente e ombroso quello di Davide. Ogni presenza all'interno dell'intreccio narrativo è ben collocata, nessun incontro sembra essere lasciato al caso, nemmeno quelli di passaggio che spargono “4 parole in tutto d'italiano” e altrettante poche noncuranti gocce di vita. Non ci sono parole con cui riassumere la trama de “La storia”, se non quelle dell'autrice stessa. Un'opera, dunque, da leggere e custodire dolorosamente nel cuore.
Laura
Vargiu
Patria –
Fernando Aramburu – Guanda – Pagg. 540 – ISBN 9788823519107 –
Euro 19,00
Leggo
uno, due libri a settimana, eppure raramente parlo nel blog dei
racconti e dei romanzi che ho letto. Non mi sento portato per fare,
non dico una recensione, nemmeno una segnalazione che abbia un
qualche costrutto sensato. È inutile che stia qui a dire i miei
difetti, ma è un fatto che non sono in grado e provo una sana
invidia per quelle recensioni ben organizzate, l’analisi, la trama,
i punti salienti, i limiti di un libro, tutto sistemato con la cura
di una tavola imbandita per la festa.
Ma
nonostante questo voglio provare a parlare di Patria,
che mi ha letteralmente rapito. È stato un regalo di Natale che una
volta scartato avevo guardato con perplessità per la mole, oltre 600
pagine, e per il tema non dei più allettanti, la lotta senza
quartiere tra irredentisti/terroristi baschi, l’ETA, e il governo
centrale spagnolo, in un arco temporale di una trentina d’anni,
dagli ultimi tempi di Franco all’abbandono delle armi nei primi
anni del duemila. Avevo altre letture da completare per cui l’ho
messo da parte per qualche giorno. Nel frattempo mi era venuta in
mente la recensione che avevo letto sul blog di Pina Bertoli e sono
andato a rileggerla. È stata la spinta che mi serviva per
intraprendere il viaggio.
Ed
è stato un viaggio pieno di sorprese e di fascino. Non mi era mai
successo con un romanzo così corposo di arrivare in prossimità
della fine e desiderare che per magia si raddoppiassero le pagine.
Non amo le classifiche ma non ho il minimo dubbio ad affermare
che Patriarientra
di forza nella mia cinquina di libri preferiti di sempre, semmai il
dubbio è sugli altri quattro.
Ma
che cosa lo ha reso ai miei occhi un romanzo così speciale?
Innanzitutto
l’intreccio sapiente tra la tragica Storia recente della sua terra
(Aramburu, l’autore, è basco) e le storie che
racconta. Le vicende reali non sono semplice cornice degli eventi
inventati, non esiste una linea netta che separi il vero dal
verosimile, leggendo non sai, e non t’interessa sapere, se quel
determinato episodio sia successo veramente o meno,
tutto esiste, allo
stesso modo in un’unica dimensione che è la letteratura.
Aramburu
è un narratore equidistante, non prende una posizione politica pro o
contro l’indipendenza della sua terra, rinuncia alla retorica della
partigianeria, ma ha uno sguardo dolente e appassionato su un mondo
che si sgretola tra attentati, torture e detenzioni, tra odi
intransigenti, piccole o grandi meschinità, e difficili gesti
solidali.
La
trama è quanto mai semplice, due famiglie di un paesino basco, da
sempre legatissime, si ritrovano per una serie di circostanze sui due
fronti opposti. Naturalmente non esistono nel romanzo i buoni e i
cattivi, esistono persone seguite con costante affetto da Aramburu
nel loro destreggiarsi nella vita. Lui non ne giudica le scelte, non
ne rimarca gli errori, tutto accade perché forse non poteva essere
altrimenti. Soprattutto gli uomini sembrano seguire un binario loro
assegnato dal proprio carattere e dall’ambiente, gli uomini vivono,
muoiono, uccidono e vengono uccisi, ma sono le donne le vere
protagoniste del romanzo, loro stabiliscono la direzione da imprimere
alla propria vita, non seguono un binario prestabilito, ma mettono
loro stesse le traversine dove ritengono giusto.
Comunque
per ambientazione, trama e personaggi, Patria potrebbe essere un
romanzo come tanti, è la scrittura a farne un’opera straordinaria.
Aramburu
non rispetta la cronologia degli eventi, sembra che ti narri gli
episodi così, a mano a mano che gli vengono in mente, come fosse
seduto accanto a te, magari con un buon bicchiere di vino in mano
(una bottiglia intera, visto quanto a lungo parla) e, alla tua
richiesta di notizie sulla sua terra, improvvisi un resoconto caotico
che punta tutto sull’immediatezza per essere compreso. A questo
aggiungi che, come avviene nelle chiacchiere tra amici, lui passa
dalla terza alla prima persona, dal passato remoto al presente
all’interno di una stessa frase.
Un
gran casino, insomma.
No,
per niente. Il fatto è che Aramburu non sta affatto bevendo vino
assieme a te davanti al caminetto, no, lui è chino a dipingere le
tessere di un mosaico e ha perfettamente in mente il disegno generale
ma preferisce pitturare ora un tassello che andrà in alto a destra,
subito dopo uno da posizionare al centro, quindi un altro che va
messo nell’angolo in basso a sinistra. E tu inizialmente apprezzi
la bellezza dei singoli frammenti, ognuno un piccolo gioiello, e solo
alla fine quando tutte le tessere saranno al loro posto guarderai
stupefatto l’insieme del mosaico. Una meraviglia.
massimolegnani
Sangue
di Giuda - Milvia
Comastri – Giraldi – Pagg. 258 – ISBN 978-88-6155-767-3 –
Euro 13,50
Quattro
donne alla deriva
Mio
nonno, che forse era un po’ maschilista, diceva che una casa con
due donne e senza un uomo su cui potessero sfogare le loro
frustrazioni era un posto infernale; non riesco a immaginare,
pertanto, come potrebbe essere una dimora in cui vivono quattro
donne, peraltro di tre generazioni. E questo libro parla appunto di
quattro persone di sesso femminile, strettamente imparentate, che
risiedono nella stessa abitazione, ma quasi come estranee, perché
nel tempo si è accumulata una indifferenza che a poco a poco è
diventata rancore e che ha fatto sì che pur così vicine
diventassero così lontane. Abbiamo così modo di conoscere Celeste,
la più anziana, che da da anni non esce e sta rintanata in casa e la
cui vita sembra imperniata su quei tre pacchetti giornalieri di
sigarette di cui non riesce a farne a meno e la cui unica
preoccupazione è la nipotina Mira, a parte la litania di una
continua imprecazione, quel Sangue di Giuda che dà il titolo
all’opera; poi c’è una donna a cui la vita sembra aver negato
tutto o quasi e che risponde al nome di Assunta, figlia di Celeste;
indi è presente, quando non in giro in cerca di una velleitaria
scrittura, Nadia, la bella Nadia, altra figlia di Celeste e madre di
Mira, una donna che senza sosta spera di sfondare nel mondo del
cinema e che ha numerosi rapporti sessuali con uomini diversi,
relazioni fugaci che illusoriamente scambia per amore, e infine
l’adolescente Mira, che detesta il comportamento della madre, tutta
tesa a prendere sul serio quello che serio non è e viceversa.
Insomma direi che è un bel campionario di donne deluse, senza un
futuro, fatta eccezione per la giovane Mira che comprende che l’unico
modo per fuggire da quella ragnatela domestica è di andarsene, di
fuggire.
C’è
un’atmosfera opprimente in questo romanzo, quasi un senso di
soffocamento tombale e il lettore arriverà a conoscere con
gradualità il carattere delle quattro protagoniste e a comprendere
cosa si celi in realtà dietro un palpabile alone di mistero. Ma non
ci sono solo donne, c’è pure qualche uomo, e direi che i
protagonisti maschili non ci fanno una gran bella figura, ma del
resto questo è in tutto e per tutto un libro al femminile, in un
mondo di sentimenti tipici di questo sesso e con dei risvolti, sul
finale, un po’ melodrammatici che personalmente avrei stemperato,
ma io sono un uomo e non una donna.
Una
cosa è certa, il romanzo di esordio di Milvia Comastri, che fino a
ora aveva pubblicato solo prose più brevi, è una rappresentazione
intimistica di quella che dovrebbe essere una normale famiglia e non
lo è, perché è evidente che non è il vivere sotto lo stesso tetto
che fa un’autentica famiglia, e in questo senso sembra quasi
rappresentare un’istituzione passata, con la sua storia particolare
propria di certe saghe del secolo scorso. Non è facile, in questi
casi, esporre ciò che si sente, si corre anche il rischio di
infarcire il tutto con dei flash back, che per fortuna l’autrice è
riuscita a limitare. Eventualmente ciò che può frenare il lettore è
costituito dalle prime pagine, che appaiono abbastanza nebulose e che
potrebbero anche distogliere l’attenzione, o addirittura far
cessare la lettura. Però, basta superare questo scoglietto, e le
cose diventano più semplici, la nebbia si schiarisce e il romanzo
fluisce senza inciampi. L’argomento non è di quelli che rientra
propriamente nei miei gusti e pur tuttavia devo dire che è riuscito
a interessarmi e che quindi questo esordio in una prosa lunga può
essere considerato complessivamente positivo e soddisfacente.
Milvia
Comastri ha
pubblicato tre raccolte di racconti: Donne,
ricette, ritorni e abbandoni (Pendragon
2005), Colazione
con i Modena City Ramblers (Historica
2012), Squilibri (Antonio
Tombolini Editore 2014) e suoi contributi sono presenti in molte
antologie. Questo è il suo primo romanzo.
Renzo
Montagnoli
Via
convento –
Roberto Corradi – Compagnia Editoriale Alberti – Pagg. 122 –
ISBN 9788893232340 - Euro 15,00
Interessante
punto di vista
“Via
Convento” è il libro d’esordio di Roberto Corradi ed è
un’interessante narrazione ironica con un pizzico di cinismo; la
scuola materna e primaria in un istituto di suore, vista e raccontata
attraverso gli occhi di un bambino, nello specifico attraverso gli
occhi di Alberto il protagonista.
“Alberto
aveva terrore puro di Babbo Natale! E forse ancora di più della
Befana. Ma quindi a casa sua la gente entrava così, come gli
pareva? Ma non si potevano studiare altri sistemi? Magari spedizioni,
consegne anche tramite conoscenti? E anche in qualche modo rafforzare
l’ingresso. Non lo so, sistemi di allarmi, blindature delle porte.
L’idea che degli estranei gironzolassero tra il suo soggiorno e la
sua cucina mente lui dormiva, lo atterro. E lo atterro a anche il
ricordo del nero che aveva visto ovunque in zona suora.”
La
narrazione rappresenta per intero la vita scolastica di Albero e dei
suoi compagni tra regole più o meno comprese e il timore inculcato
loro dai grandi, dalle suore, da un’istituzione: “il grottesco di
un mondo fuori dal mondo”
“La
delusione era maturata lì. Tutta quell’annata già non era
piaciuta ad Alberto. E ancora meno gli era piaciuto dover ammettere
la tranquillità del regno di suor Liberata e Governata di Dio. E
questo era un problema che montava profondamente le sue convinzioni,
lo impensieriva, lo incupiva. Suor Liberata non poteva essere
rimpianta.”
Lo
stupore, la bellezza e l’ingenuità dei bambini è qualcosa che
rallegra il cuore e Roberto Corradi con il suo narrare ricolma di
gioia l’anima. Via Convento sa di buono, di vero, di ingenuo, una
lettura che ti lascia, fino alla fine, un sorriso stampato sulle
labbra.
“Mi
scusi, suor Liberata: ma non abbiamo studiato che gli uomini
discendono dalla scimmia? E se discendono dalla scimmia, come faceva
Adamo a essere lo stesso il primo?”
La
scritta del dell’autore è matura e ben sviluppata, riesce a far
vivere in modo chiaro i luoghi e i personaggi, la storia è narrata
con grande maestria. Un libro che consiglio, ma soprattutto Roberto
Corradi è un autore da tenere sott’occhio.
“Il
contadino che doveva portare al mercato quei cinque chili di mele del
cazzo, quando avrebbe dovuto aspettare per capire se, ricevendo mille
lire al chilo dopo averne speso duecento ogni mezzo, lo stavano
prendendo per il culo oppure no? Va bene, d’accordo: la volgarità
non sarebbe stata d’aiuto.”
Katia
Ciarrocchi



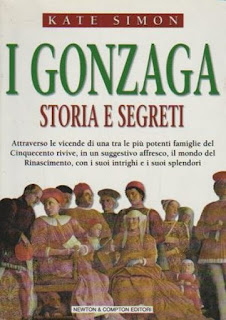







Nessun commento:
Posta un commento